[Sommario IA] Bielefeldt evidenzia la continuità tra Ch’an classico e Dōgen riguardo all’unità di pratica e illuminazione, ma sottolinea una maggiore enfasi in Dōgen sull’aspetto rituale ed etico della pratica illuminata.
Bielefeldt interpreta il “non pensare” di Dōgen come tecnica meditativa, un’interpretazione considerata limitante dall’autore della recensione, che critica l’approccio di Bielefeldt come eccessivamente storico e metodologicamente ristretto.
La recensione critica la metodologia “secolare e positivistica” di Bielefeldt, accusandola di trascurare la dimensione esistenziale e mitica della vita e dell’esperienza spirituale di Dōgen.
Bielefeldt viene apprezzato per aver liberato Dōgen dal settarismo Soto, ma viene contestata la sua interpretazione di shikan taza come semplice tecnica e non come metafora centrale del pensiero di Dōgen.
La recensione conclude che, nonostante i limiti metodologici, il lavoro di Bielefeldt rappresenta un contributo importante agli studi sullo Zen, restituendo Dōgen al contesto storico intellettuale del Ch’an. [/S]
[Precedente] Riguardo alla continuità e discontinuità tra il Ch’an classico e Dōgen, Bielefeldt sostiene che, mentre la visione classica improvvisa dell’unità di pratica e illuminazione (the classical sudden view of the unity of practice and enlightenment) rimane costante in entrambi, l’enfasi nel Fukan zazen gi rivisto (1243, ndr) è sull’atto rituale ed etico nella pratica illuminata piuttosto che sulla mera evitazione della discriminazione illusa.
Il cambiamento va dalla questione epistemologica del riconoscimento alla questione etica della partecipazione; dalla ricerca interiore all’espressione esteriore; dalla pura coscienza all’azione liberata. In questo senso, la pratica illuminata è inseparabilmente congiunta con la meditazione seduta. In questo modo, Dōgen perfezionò gradualmente la sua visione della meditazione all’interno del contesto ideologico della tradizione di saggezza (improvvisa) del Ch’an.
[Pubblichiamo alcuni materiali relativi alla zen, alle sue origini e al suo sviluppo nella convinzione che molto si possa indagare non mossi da una intenzionalità speculativa e intellettuale, ma dall’esigenza di chiarire i cardini fondamentali del pensiero di Dōgen – e dello zen classico – quali, tra gli altri, l’equiparazione tra pratica e illuminazione o il senso stesso di pratica e tanto più quello di illuminazione. Cardini non secondari per la vita e l’esperienza di un contemplativo che a ogni istante del suo esistere si confronta con questi temi e dunque si interroga e propone la sua interrogazione.
Dopo la pubblicazione di alcuni materiali che preparino il terreno e illuminino su una complessità mai esaurita, affronterò questi temi:
1. La realtà che definiamo Essere, o natura autentica.
2. Cosa si intende per illuminazione nel Sentiero e l’irrealtà dell’illuminazione istantanea.
3. Cosa si intende per pratica e l’azzardato e relativo parallelo tra pratica e illuminazione.
4. La demitizzazione della nozione di pratica e di illuminazione e la reale tensione tra divenire ed Essere.
5. Formazione e contemplazione in una via spirituale nel XXI secolo. Qui la raccolta dei post]
In questo contesto, mentre approfondisce il non pensare (hi shiryō), una delle nozioni chiave che appare nel testo rivisto del Fukan zazen gi, Bielefeldt interpreta il termine come riferito a una tecnica di meditazione. Di conseguenza, è vincolato dal suo metodo storico, tanto che la sua esposizione su questa nozione è la meno soddisfacente del libro, come spiegherò più avanti. Anche così, propone una visione altamente suggestiva sul rapporto tra non pensare e shikan taza (semplicemente seduto, ndr), argomentando il ruolo svolto all’interno di quest’ultimo dal kanna (“investigazione koan”) Zen, un metodo considerato nei circoli settari Sōtō come appartenente alla tradizione Rinzai e quindi incompatibile con la setta Sōtō.
In ultima analisi, Bielefeldt non vede alcuna validità nella rivendicazione ortodossa Sōtō dell’unicità di shikan taza come tecnica che la renderebbe fondamentalmente diversa e incompatibile con tutti gli altri metodi. Allo stesso modo, come nota nella sua conclusione, tale rivendicazione esclusivista di unicità, quando considerata nel più ampio contesto comparativo del Buddhismo Kamakura (1185-1333, ndr), trova significativi paralleli, ad esempio, nelle tradizioni di Shinran e Nichiren.
Considerato in congiunzione con il suo saggio “Ricarving the Dragon: History and Dogma in the Study of Dogen,” il presente lavoro di Bielefeldt in esame è emblematico dei suoi sforzi costanti e persistenti per ricostruire la vita di Dōgen e le origini dello Zen di Dōgen. In questa meritevole impresa accademica, Bielefeldt ha adottato una posizione non settaria – quella che lui, in modo un po’ autoconsapevole, definisce “secolare” e “positivistica,” distaccandosi nettamente dall’apologetica settaria.
Questa postura metodologica è salutare e benvenuta nella misura in cui libera lo Zen di Dōgen da alcune premesse malsane del dogmatismo settario; eppure, ha anche portato in qualche misura Bielefeldt a gettare il bambino con l’acqua sporca, per così dire. Ciò che è problematico nella storiografia di Bielefeldt, quindi, ha a che fare principalmente meno con le commissioni che con le omissioni (has primarily to do less with commissions than with omissions).
Ciò che ho specificamente in mente è il totale rigetto dalla sua metodologia, ad esempio, della dimensione esistenziale della lotta spirituale di Dōgen e dell’eventuale esperienza di illuminazione sotto Ju-ching a T’ien-t’ung – il fattore decisivo nella auto-definizione di Dōgen, e un tema paradigmatico o mitico che egli ha messo in atto per tutta la sua vita – come nulla più che parte del dogma agiografico del Soto, che ha le sue origini nella parte finale della vita di Dōgen e che è stato successivamente rinforzato dagli apologeti del diciottesimo secolo. Ciò che Bielefeldt sta effettivamente facendo, tuttavia, è scartare non solo il dogma ma, cosa più importante, anche il mito. I temi mitici e i cambiamenti storici si interpenetrano l’uno con l’altro in modo da redimersi a vicenda. Solo allora le origini storiche possono diventare genuinamente e totalmente storiche.
Pertinente alle osservazioni precedenti è l’insistenza di Bielefeldt nel presente libro nel trattare Dōgen come un maestro di meditazione, piuttosto che come un pensatore religioso, e nel considerare shikan taza come una tecnica, piuttosto che come la metafora radice per l’enormemente ricco e complesso universo simbolico di Dōgen.
Questa limitazione autoimposta della sua procedura – ironica analogia con quella della soteriologia “protestante” dell’ortodossia Ch’an nella sua analisi – ha inibito fatalmente l’autore nel trattare Dōgen il pensatore. Il caso in questione è più chiaramente evidenziato nel trattamento del non-pensiero da parte di Bielefeldt, che dicotomizza indebitamente Dōgen meditatore e Dōgen pensatore, limitandosi agli stretti confini del non-pensiero come tecnica di meditazione. Di conseguenza, egli sorvola sulle implicazioni ermeneutiche di vasta portata dell’identificazione della meditazione di Dōgen con il non-pensiero come pensiero autentico.
Per tutti questi motivi, siamo immensamente debitori a Bielefeldt per aver liberato Dōgen dal settarismo della Soto, nella migliore tradizione degli studi non settari, e per aver restituito lui e la tradizione della Soto alla storia intellettuale del Ch’an e dello Zen. Dopo tutto, Dōgen non era, non è e non sarà né settario né non settario. Hee-Jin Kim
MANUALI DI MEDITAZIONE ZEN, Di Carl Bielefeldt. Berkeley e Los Angeles: University of California Press, 1989. Pp. 259. ISBN 0-520-06056-3.
Recensione del libro: “Dogen’s Manual of Zen Meditation”, by Carl Bielefeldt
Autore: Kim, Hee-jin
Fonte: The Eastern Buddhist=イースタン・ブディスト
Volume v.23 n.1 New Series
Date 1990, Pages 141 – 145
Publisher Eastern Buddhist Society, Otani University
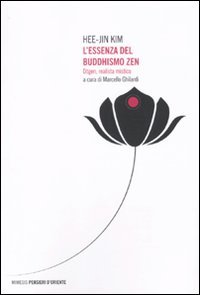
Funzionale Sempre attivo
Preferenze
Statistiche
Marketing