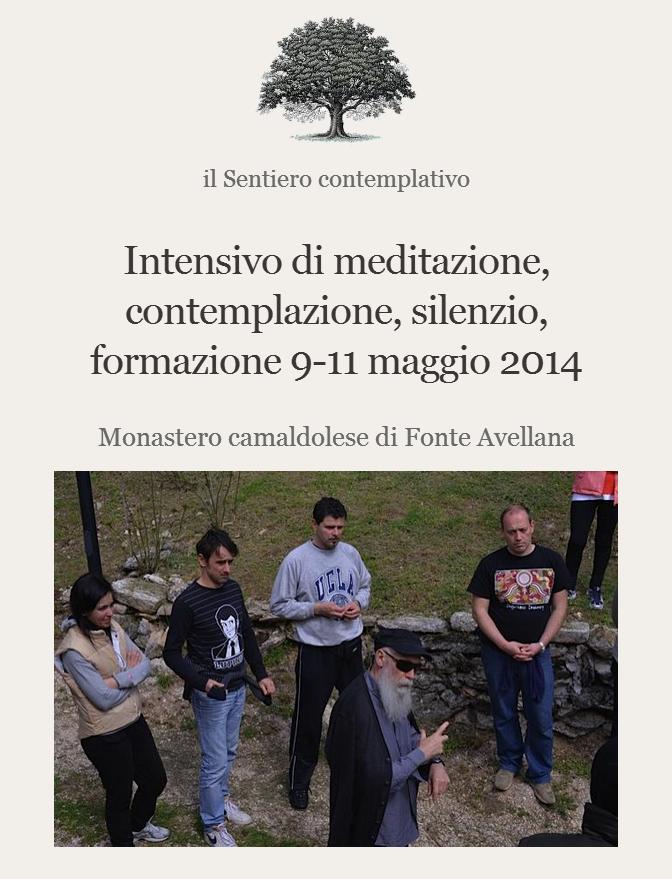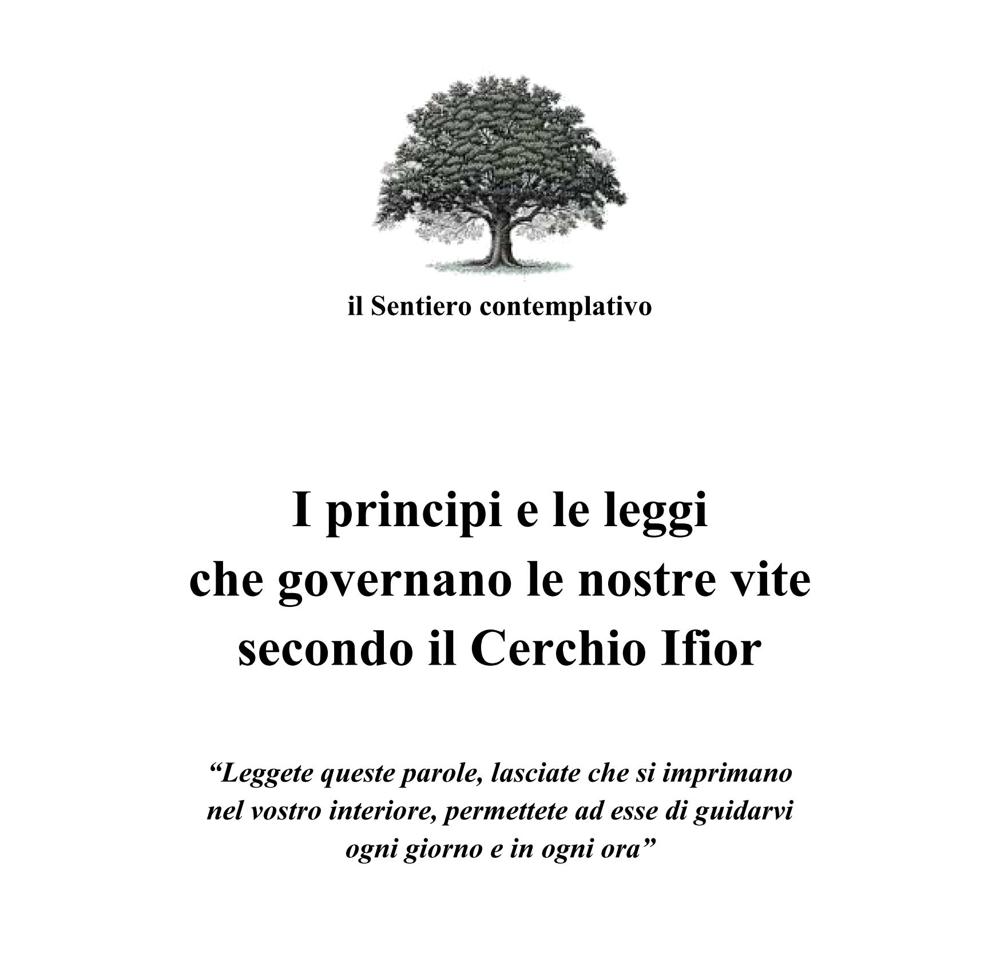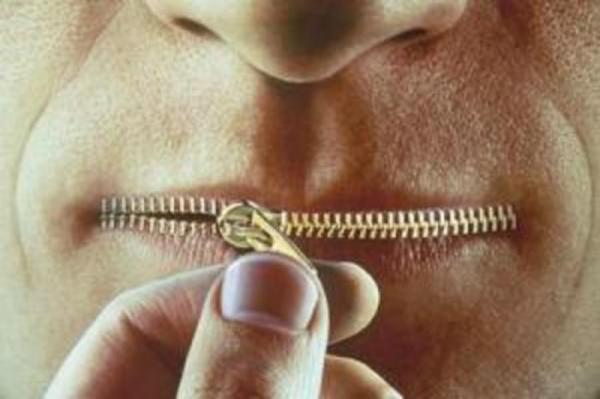Conosci te stesso
Base essenziale dell’intero insegnamento etico-morale delle Guide, contemporaneamente principio, legge evolutiva e strumento per arrivare alla vera comprensione di se stessi e della Realtà.
Così in alto così in basso
Concetto usato spesso dalle Guide per significare che certe caratteristiche funzionali e strutturali della realtà si ripetono in maniera costante nei loro elementi di base su tutti i piani di esistenza, anche se adeguate alle caratteristiche peculiari di ogni piano.
Ad esempio il ciclo della vita e della morte non riguarda solo il corpo fisico: anche il corpo astrale e il corpo mentale possiedono un ciclo identico. Considerando che questo ciclo è un mutamento e non una fine, il ciclo si ritrova anche sugli altri piani di esistenza: per esempio per quanto riguarda il corpo akasico, il corpo della coscienza, abbiamo l’analogo ciclo nel nascere e completarsi della costituzione della coscienza.
A un livello ancora più alto è riconoscibile nella formazione e nel riassorbimento di ogni Cosmo da parte dell’Assoluto.
Incominciare da poco e da vicino
Non impegnatevi – esortano le Guide – con le grandi battaglie sociali o umanitarie se prima non avete combattuto quelle a favore di chi vi sta vicino perché ciò appagherebbe e gratificherebbe il vostro Io ma lascerebbe irrisolti i vostri più impellenti bisogni di comprensione interiore!
La vostra attenzione deve seguire una sorta di spostamento da voi stessi verso l’esterno: essa deve essere posta per prima cosa su voi stessi e sulle persone che condividono più da presso le vostre esperienze.
La vostra società attuale tende invece a trascinare la vostra attenzione lontano da voi.
Non lasciatevi ingannare da falsi miraggi che sembrano poter tacitare con facilità le vostre responsabilità: è comodo altruismo aiutare chi non conoscete e mai, probabilmente, conoscerete veramente.
È certo meglio adottare un bambino a distanza che non fare niente di niente per gli altri, ma non è la stessa cosa che aiutare il bambino della porta accanto che, magari, ha altrettanto bisogno (e non solo economico).
Legge dell’ambivalenza
Legge presentata in maniera “scherzosa” da Scifo ma, in realtà, fondamentale per chi è alla ricerca della giusta comprensione della realtà.
Essa afferma che “ogni elemento della realtà ha apparentemente una duplice natura, positiva e negativa, ma l’attribuzione della positività o della negatività non è intrinseca all’elemento in se stesso bensì è operata dall’osservatore, e quindi relativa ad esso”.
Saper osservare la realtà secondo entrambe le attribuzioni costituisce già un primo passo importante per ridurre di molto l’idea frammentaria che possediamo della Realtà.
Per fare un esempio consideriamo una bottiglia di latte da un litro contenente solo mezzo litro di latte.
A seconda di chi la osserverà essa verrà considerata «mezzo piena» o «mezzo vuota», sebbene in realtà per la bottiglia in questione siano intrinsecamente vere entrambe le affermazioni.
Legge dell’equilibrio
È una legge, riconosciuta anche dalla scienza, è valida in tutto il Cosmo ma non riguarda la sola materia fisica, bensì tutte le componenti della Realtà e tutte le materie dei vari piani di esistenza.
Secondo questa legge tutto quello che avviene nella Realtà tende a ritornare ad uno stato di equilibrio, condizione ottimale della Realtà.
Legge dell’oblio
Legge che non permette all’incarnato di avere memoria delle sue vite precedenti.
Questa legge può non essere operante nei casi in cui l’incarnato ha la necessità, per comportarsi nella maniera più utile per la sua comprensione, di ricevere la spinta da agganci con esperienze vissute in vite precedenti.
Si tratta, però, solo di brandelli limitati di ricordi, spesso vissuti come sogni o fantasie.
La forza della legge dell’oblio si attenua quando si è alle ultime incarnazioni, nel corso delle quali si può avere una visione più ampia e dettagliata di quello che è stato il cammino percorso nelle varie vite.
Messaggio esemplificatorio
Molto spesso ci si chiede perché il ricordo delle vite precedenti non accompagna l’individuo nel corso delle sue incarnazioni e, questo, potrebbe in un primo momento anche apparire non giusto, in quanto il fatto di avere dei ricordi degli errori compiuti potrebbe aiutare a far sì che quegli stessi errori non vengano più compiuti.
Ma, in realtà, non è così, esiste la legge dell’oblio che fa dimenticare, al momento della nuova incarnazione, tutto ciò che si è stati, e questo è molto giusto: infatti se si ricordassero tutte le azioni compiute nel corso delle vite precedenti, se si avesse coscienza di tutte le cattiverie, di tutte le meschinità che si sono commesse, dei tradimenti, degli omicidi, delle violenze e via dicendo, l’individuo vivrebbe la sua nuova vita o con grandissimi sensi di colpa che impedirebbero di agire, oppure tormentandosi continuamente nel dolore e nella sofferenza.
Invece, non sapendo quello che è costata la propria evoluzione, cioè tutti i passi necessari (anche se brutti e dolorosi) che si sono dovuti attraversare, si può vivere la vita partendo da una base di serenità, affrontando tutte le esperienze come se fossero nuove.
Se non vi fosse la legge dell’oblio di fronte ad ogni esperienza che proponesse una scelta dolorosa di qualche tipo, inevitabilmente, l’individuo si fermerebbe e il fermarsi è sempre un danno per l’evoluzione: è molto meglio sbagliare piuttosto che non sbagliare non facendo nulla.
Lo scopo delle vite è quello di prendere coscienza di un determinato stato interiore, e per far questo è necessaria l’azione, azione che verrebbe inibita, bloccata, frenata dal ricordo di esperienze negative vissute in epoche precedenti.
Soltanto quando l’individuo avrà raggiunto una buona evoluzione e di conseguenza un certo equilibrio interiore, allora, qualche ricordo potrà affiorare, anche se questo affiorare sarà soltanto a livello di sensazione; d’altra parte bisogna ancora considerare che certe attrazioni per epoche storiche, per determinati paesi e paesaggi, molto spesso sono motivati dal fatto di aver vissuto in quell’epoca o in quel paese, e questi sono i primi pallidi riscontri dei ricordi che stanno affiorando.
Legge di causa-effetto
È l’analogo in campo spirituale della legge di azione e reazione della fisica: ogni azione compiuta dall’uomo incarnato provoca un effetto che ricade (in positivo o in negativo) su chi l’ha compiuta.
Viene spesso definita anche Legge del Karma o, più semplicemente, Karma,
Per una spiegazione più articolata vedere il termine «karma» nei volumi successivi.
Messaggio esemplificatorio
La tradizione afferma che un giorno, più di 2000 anni fa, un ometto compito e ingegnoso saltò, in completa nudità, fuori dalla sua vasca da bagno esclamando con grande eccitazione:
«Eureka. Eureka! ». «Ho trovato! Ho trovato! » esclamava dunque il nostro ometto, un tale Archimede in quel di Sicilia scattando fuori dalla vasca da bagno in cui si era immerso per cercare ristoro dalla calura tipica di un’assolata giornata estiva della Trinacria, nel vedere l’acqua che debordava dal recipiente inondando il pavimento.
Sembra un comportamento piuttosto infantile e sciocco per essere quello di un genio riconosciuto e stimato ancora dopo più di due millenni, e, certamente, se un vostro figlio si comportasse nell’identico modo mal gliene incoglierebbe. Eppure, supponendo che la tradizione non abbia falsato la verità dell’avvenimento e che le cose siano andate proprio così come vengono ricordate ancora oggi, Archimede aveva un motivo più che valido per esultare poiché aveva avuto l’intuizione folgorante e formidabile che portò in seguito alla formulazione della legge di azione e reazione e ciò – onore al pensatore – dalla semplice osservazione di un effetto di questa legge.
Voi direte: «D’accordo, avrà anche compreso qualcosa di importante ma, invece di esultare per avere bagnato il pavimento, avrebbe fatto meglio a preoccuparsi della poveraccia che avrebbe dovuto, poi, asciugare in terra!»
Giusto, ma non siamo qui per giudicare il comportamento etico o morale di Archimede, né per portare avanti una qualche crociata sociale in difesa delle classi inferiori di duemila anni fa: siamo qui, invece, per ripensare un attimo alla formulazione della famosa legge di Archimede: “Un corpo immerso in un liquido riceve una spinta verticale dal basso verso l’alto uguale al peso del liquido che sposta”.
In altri termini, e generalizzando quest’enunciazione, possiamo dire: “Ogni azione provoca una reazione”.
La mia non sarà certo una formulazione scientifica ineccepibile di questa legge, ma state sicuri che, se ve l’ho presentata in questa forma, è perché essa tornerà più utile per il discorso che, in seguito, vi verrà fatto.
Scifo
Guardatevi intorno: la legge di azione e reazione è universalmente valida attorno a voi; non vi è possibilità – neanche con i più raffinati mezzi che la tecnica umana più avanzata possiede – di impedire che nel mondo fisico a una qualunque azione corrisponda una reazione ben precisa: tirate il petalo di un fiore e il petalo si staccherà, mettete del ghiaccio sul fuoco e il ghiaccio si scioglierà, aprite un rubinetto e, se vi è acqua nei tubi, essa incomincerà a fluire. Non vi è azione che voi possiate immaginare che non abbia la sua reazione, più o meno evidente, più o meno percepibile.
Boris
È tutto così ordinato, amici, tutto così ben congegnato nel piano in cui attualmente siete coscienti di vivere che, a chi è religioso, può venire da immaginare Dio come un pignolo architetto, bene attento a tutto quello che accade e velocissimo nel predisporre la reazione adeguata alla sconfinata quantità di azioni fisiche che osservate in continuazione intorno a voi.
Insomma, è un lavoraccio così enorme che bisogna proprio convincersi che Dio è infinito, perché solo chi è così infinito da avere anche una pazienza infinita può non essersi ancora annoiato a fare andare avanti tutto il creato!
Zifed
Eterna, immutabile, onnipresente, infallibile legge di causa ed effetto! Basteresti da sola a convincere dell’esistenza di Dio anche l’ateo più incallito: sempre che davvero volesse cercare di trovare la prova dell’esistenza di un Dio anche solo esaminando la natura!
Tu sei giusta e imparziale; nessuno nei millenni può mai imputarti di aver risposto in modo diverso e fazioso a una stessa azione, indipendentemente dal sesso, dalla posizione sociale, dalla cultura, dalla religione o da qualunque altro parametro che diversifichi in qualche modo l’agente dall’azione.
Cosa sarebbe la scienza, senza di te? Senza di te crollerebbe miseramente il tanto osannato metodo scientifico perché cesserebbe la ripetibilità del fenomeno; la scienza non avrebbe più anche la minima certezza, non avrebbe avuto addirittura mai la possibilità di nascere e persino il nostro Archimede non avrebbe avuto la possibilità di passare alla storia. E cosa sarebbe la civiltà dell’uomo, senza di te? Le macchine diverrebbero inutili perché ingovernabili, non potrebbe esservi nulla, né arte, né letteratura, né musica; l’uomo vagherebbe ignudo e inebetito su di un pianeta imprevedibile e folle, impaurito dall’eterna e incontrollabile incognita dell’attimo successivo. Anzi, se volessimo arrivare ancora più in là nella nostra ipotesi, dovremmo dire che, senza di te, gloriosa legge, l’uomo non avrebbe avuto neppure la possibilità di sopravvivere, se non addirittura di esistere. Se tu venissi a mancare all’improvviso non esisterebbero più sistemi solari, i pianeti andrebbero in frantumi collidendo l’un l’altro o si fonderebbero nelle fornaci solari, oppure si perderebbero nell’immensità degli spazi siderali, le galassie sparirebbero nel caos e lo stesso universo diventerebbe una cosa ancora più inimmaginabile di quanto esso già non sia per voi.
Scifo
Cosa potrebbe restare dell’attuale cultura umana? Potrebbero forse continuare a esistere le scienze matematiche, perché dire che uno più uno è uguale a due non è che astrazione mentale… ma che dite, amici?… Mi stanno dicendo che non potrebbe essere più neanche così… Come? Ah, è vero, è proprio vero, Boris: difetto di logica, anche il cervello basa il suo funzionamento sulla legge di azione e reazione, tanto che mancando la legge, gli schemi logici salterebbero e non avrebbero più alcun senso.
Devo andare ancora più avanti? Beh, veramente… Ah, ho capito: il cervello e l’intero corpo si basano su sottili azioni e reazioni mancando le quali verrebbe a disorganizzarsi la materia e il corpo non esisterebbe più…. che dico, il corpo?… l’intero universo si scioglierebbe! Mamma mia! E dire che non avevo mai pensato a niente che si avvicinasse a tutto questo.
Zifed
Certo, abbiamo parlato della legge di azione e reazione o di causa ed effetto, se così preferite, sotto un punto di vista strettamente concreto, meramente fisico.
Eppure essa opera ben oltre a quel ristretto ambito in cui l’abbiamo collocata fino a questo punto. La legge di azione e di reazione impera anche nel campo spirituale e riveste pure in esso un’enorme importanza, tanto che si può affermare in modo figurato che se Dio è l’architetto che ha edificato in modo così mirabilmente impeccabile l’intero creato, la legge di causa ed effetto è la Sua mano protesa a regolare con precisione assoluta l’armonia celata anche nell’evento che più può apparire disarmonico alla vostra osservazione.
Moti
Legge di economia
Legge secondo la quale tutto ciò che accade è sempre fatto accadere con il mezzo più semplice. Veniamo spesso richiamati a questa legge quando tendiamo ad alimentare i nostri sogni o i nostri desideri auto-illudendoci, al punto di ritenere vere anche le cose più strane ed evidentemente improbabili.
È per questo motivo che le Guide ci ricordano con costanza che la Verità non può mai essere illogica e, perciò, ci ricordano sempre di non prendere mai per oro colato quello che viene proposto da loro o da altre fonti ma di sottoporlo sempre ad un’attenta analisi in modo da non cadere in illusioni non soltanto inutili ma, spesso, anche pericolose.
Nascere ogni giorno
È importante arrivare a comprendere che niente è mai fisso e immutabile e saper conservare l’umiltà di riconoscere che quello che si crede vero oggi, domani potrebbe essere riconosciuto come una verità solo relativa e non assoluta.
Per questo motivo, ci è stato insegnato, bisogna difendere le proprie convinzioni, ma essere pronti a modificarle quando si rivelano non aderenti alla realtà come si credeva.
Questo comporta, come conseguenza, essere sempre pronti e disponibili al cambiamento, ovvero a rinascere diversi ogni volta che una nuova comprensione amplia la nostra visione della realtà.
Messaggio esemplificativo
Quante volte nel corso dei nostri incontri vi abbiamo detto di nascere ogni giorno; e quante volte queste parole vi sono passate sopra senza lasciarvi il minimo segno; e quante volte ancora ci avete mostrato di non comprendere il senso delle nostre parole!
Nascere, figli miei, nascere ogni giorno comporta ed implica molta buona volontà, un grande desiderio di cambiare, d’essere diversi, di rinnovarsi, di apparire al nuovo giorno modificati interiormente. E per meglio comprendere il senso delle nostre parole, cercate di vedere che cosa rappresenta la nascita di una nuova, dolcissima creatura, e che cosa implica – direttamente e indirettamente – il suo venire al mondo; e, ancora, quali conseguenze porta a tutte le altre persone che le sono accanto.
Osservando la nascita di un bimbo, potreste arrivare a comprendere che nascere significa essere nuovi, proiettarsi all’esterno, desiderare nuove esperienze, arricchirsi incontrandosi e comunicando con gli altri, aprirsi alla vita nella certezza che questa riserverà gioia, felicità, amore.
Quel piccolo essere appena nato, infatti, porta con sé tutti questi attributi, tutte queste qualità, ed è proprio da lui che dovete prendere l’esempio per far sì che anche voi, ogni giorno, non appena riaprite gli occhi da un giusto sonno, vi ritroviate in quella condizione interiore che già in altri tempi vi è appartenuta. Ma nascere ogni giorno non significa – e ci tengo a sottolineare quanto sto per dire – dimenticare le proprie responsabilità, non significa cancellare “con un colpo di spugna” quanto si è mosso nei precedenti giorni.
Siate, dunque, sempre consapevoli del vostro ruolo, del compito che siete stati chiamati a svolgere nel mondo della materia. Ma non lasciatevi sopraffare da queste vostre responsabilità: siate consapevoli della loro presenza ma non fate che esse diventino per voi pesanti catene che vi avviliscono, vi intristiscono, vi rendono simili a maschere greche immortalate nelle loro smorfie di dolore e paura; agite in modo che esse diventino ogni giorno degli stimoli nuovi che vi vivificano, che vi rendono attivi, vivaci, allegri, proiettati con piacere verso l’azione.
Nascere ogni giorno significa lasciare dietro alle vostre spalle l’amarezza, la delusione, la rabbia, il contrasto, l’odio, l’infelicità, la tristezza, la stanchezza, l’invidia, la gelosia, il dolore, ma soltanto in quegli aspetti che sortiscono su di voi e in voi un effetto negativo quando vi rendono apatici, inattivi, chiusi; mantenetene, invece, vivo il ricordo, perché in questo modo vi faciliterete il compito arduo di non muovere più quelle cause che li hanno scatenati.
Nascere ogni giorno significa aprire gli occhi alla nuova luce, al nuovo giorno, ricordando quello che è stato il passato e ricominciare tutto in modo nuovo, diverso, fino a quando, giunti ad un buon punto del vostro cammino, non ne avrete più bisogno, perché il vostro essere sarà vivo.
Ci chiedevamo, all’inizio di questo discorso, che cosa rappresenta la nascita di un bimbo. Bene, voi lo sapete meglio di me: una nascita porta sempre con sé – tranne rari e tristissimi casi – felicità e gioia di vivere ma, soprattutto, stimoli nuovi a proseguire; così la vostra giornaliera rinascita spirituale vi deve modificare interiormente, come abbiamo già detto.
Se poi analizziamo tutti gli effetti collaterali che questa vostra rinascita può avere sugli altri, sulle persone che in qualche modo vivono accanto a voi, scopriamo che come minimo la vostra gioia, la vostra serenità, la vostra capacità di sorridere servirà da esempio agli altri e, in alcuni casi, potrà anche riuscire a coinvolgere totalmente gli altri attraverso una sorta di contagio psichico.
Ci rendiamo conto, figli cari, quando veniamo a parlarvi, delle difficoltà che incontrate nel mettere in pratica le cose che vi diciamo; già in altre occasioni ci eravamo soffermati ad analizzare queste vostre difficoltà; pur tuttavia abbiamo continuato a parlare, a impartirvi insegnamenti, ripetendo in alcune occasioni anche le stesse cose, a rischio di diventare monotoni e noiosi.
Se, abbiamo ripetuto sempre le stesse cose non è perché non avevamo altro da dirvi, ma perché siamo sicuri – ricordate che noi crediamo nell’uomo e nelle sue capacità – che il nostro ripeterci vi sarà utile per mettere in pratica l’insegnamento astratto.
E così, se da sette anni vi abbiamo detto “nascete nuovi ogni giorno”, è perché speriamo che in almeno uno dei giorni della vostra intera esistenza voi riusciate veramente a farlo.
«E che importanza può avere se è soltanto uno in mezzo a centinaia?». Sento che vi chiedete. Quando noi vi parliamo, quando noi vi porgiamo degli insegnamenti, non pretendiamo che li mettiate subito in atto e nel modo migliore, ma speriamo e ci auguriamo soltanto che in un unico giorno della vostra vita riusciate ad essere così quali noi vi prospettiamo in tutto il nostro disquisire.
Quindi basta un giorno, uno soltanto, e se ognuno di voi che ci ascolta, che ci parla, che ci chiede e che si getta tra le nostre braccia, riesce soltanto a risvegliarsi un mattino innovato, vivo e vero, significa che le nostre parole non sono state vane, ma anche che quell’individuo ha raggiunto uno dei suoi tanti traguardi.
Io vi auguro di raggiungere quotidianamente tanti di questi traguardi, fino ad arrivare a poter dire assieme alle Guide che vengono a parlarvi, che la vita è degna d’essere vissuta e assaporata in ogni suo aspetto, sia esso anche il dolore, e che la vostra presenza nel mondo fisico è un diritto-dovere che avete nei confronti di voi stessi e delle altre creature che sono con voi nel mondo fisico; e, infine, che la luce che vi richiama alla vita ogni giorno ha sempre colori nuovi, diversi, e più luminosi.
Imparate a nascere nuovi ogni giorno, dimenticando ciò che vi ha tenuti fermi, bloccati, ricominciando tutto in maniera sempre nuova e diversa per poter raggiungere la pace interiore e la serenità tanto desiderate.
Fabius
Nulla succede a caso
Modo di dire delle Guide legato alla concezione che tutto quello che accade all’individuo incarnato è mirato alla sua evoluzione, ed è adeguato alle sue necessità di comprensione e, di conseguenza, di sviluppo evolutivo.
La casualità – affermano – non esiste, ma tutto rientra nella logica del miglior bene possibile per l’individuo, tenendo presente l’as-sunto che l’individuo è, comunque, incarnato sul piano fisico essenzialmente per raggiungere una comprensione sempre più ampia e sempre più strutturata. In quest’ottica gli stessi momenti di difficoltà, per quanto pesanti e tormentosi possano essere, guardati con obiettività a distanza di tempo, quindi senza più il coinvolgimento psico-emotivo diretto, hanno in sé evidenti semi di utilità o, addirittura, di necessità per facilitare la comprensione.
Qui ed ora: vivere il presente
Ci è stato detto più volte che l’essere attaccati al passato o vivere esclusivamente per delle mete future non è la maniera migliore per condurre la propria vita, anche dal punto di vista evolutivo: per acquisire comprensione ed evoluzione basterebbe osservarsi momento dopo momento proprio nell’attimo in cui i nostri meccanismi stanno agendo nel corso delle esperienze che si attraversano.
Messaggio esemplificativo
Tu, uomo, sei ieri, oggi, domani. Fra i tanti doni che ti sono stati dati affinché avessi i mezzi per scoprire in te la fonte della saggezza, ne hai ricevuto uno di cui neppure ti accorgi se non per usarlo in modo errato: il tempo.
Tu vivi, attimo dopo attimo, con la sensazione di un prima e di un poi che, in realtà, non hanno esistenza se non all’interno del tuo concepire.
E questo scorrere di attimi ha la funzione di farti da metro per la tua evoluzione di essere incarnato, fornendoti una base per il tuo concepire non solo te stesso ma anche gli altri e l’ambiente in cui esisti. È un dono, un immenso dono quello che ti è stato fatto, eppure tu lo svilisci con il tuo agire e ancora di più con il tuo pensare, poiché anche il dono più benevolo e benefico diventa malevolo e malefico, se il suo uso non è quello per il quale era stato donato. Moti
Dunque, creature care, riallacciandoci alla favola di Ananda vi dico che voi siete quei fiori, né più né meno, anche se può essere che questo paragone vi appaia come una riduzione del vostro modo d’essere.
Non è così: il vostro valore all’interno dell’universo non è quello che voi, nella vostra arroganza, siete soliti attribuirvi.
Ripeto: siete come quei fiori ma potrei dire – altrettanto giustamente – che siete dei parassiti e voi non avreste alcun diritto di sentirvi offesi, o risentiti, oppure sminuiti. Non esiste, infatti, una scala di valori tra l’essere delle cose, delle piante, degli animali e dell’uomo: esistono soltanto dei diversi modi di essere adeguati alle diverse necessità evolutive. Così è errato affermare che l’uomo è – per sua natura – superiore al fiore, poiché l’essere del fiore, all’interno del mondo in cui è inserito, è altrettanto adeguato e specializzato dell’essere umano. Si può parlare semplicemente di diversità, di differente ampiezza di sentire, ma non si può fare una graduatoria in cui un «sentire» sia classificato come migliore di un altro.
Il «sentire» se stessi ed il proprio ambiente è, infatti, nella sua radice, identico per tutti gli esseri, perché tutti gli esseri hanno la stessa essenza. Se proprio volessi fare una scala del «sentire» (senza preoccuparmi di dire una grossa stupidaggine o, come minimo, un’enorme superficialità) allora potrei dire che il terzo fiore della storia è più elevato della maggior parte degli uomini. Perché? Perché esso vive con semplicità la sua vita da fiore del giorno, sempre presente a se stesso e ai limiti che la sua natura gli impone.
E voi, creature, riuscite a fare lo stesso? Oppure vivete il vostro tempo rimasticando dentro di voi ciò che è passato oppure rinnegando il vostro essere, nella speranza di un futuro che – nel momento in cui voi lo cercate – non è e non può essere il vostro in quanto non siete ancora pronti a viverlo? Vivete il vostro presente, creature, restando il più possibile aderenti a voi stessi.
Non voglio, con queste mie parole, affermare la logica del «carpe diem» in quanto il vivere alla giornata presuppone – nella concezione antica – il non porsi alcuna domanda e, quindi, il non scavare all’interno di se stessi. Voglio invece dirvi e farvi capire che il vostro presente, quel presente che vivete di solito con indifferenza e noncuranza voltandovi più volentieri all’indietro o protendendovi più volentieri in avanti, è in realtà quello che ha più importanza. Esso, infatti, come ha espresso il terzo fiore, ha in sé i frutti del passato e i germogli del futuro ma, più importante di ogni altra considerazione, ha in sé il vostro «sentire» più vero, il vostro Io più reale perché è l’Io del momento, un Io diverso da quello di un attimo prima e diverso da quello che sarà un attimo dopo.
Il presente dunque – anche se a voi che lo vivete può non apparire tale – non è statico, bensì grandemente dinamico e vi dà esattamente la misura di ciò che siete, attraverso le risultanze di ciò che siete stati e le premesse di ciò che potrete essere.
Vivete il vostro presente con la coscienza di viverlo, poiché esso è contemporaneamente vostro passato e vostro futuro; spiegate nel presente il vostro sentire e vivrete la vostra condizione umana nel modo più giusto e facendo l’uso migliore del dono che vi è stato fatto dal Creatore.
È il «conosci te stesso» che fa capolino dalle mie parole, ma un «conosci te stesso» che ha qualche sfumatura in più, un «conosci te stesso» che presuppone una coscienza sempre cangiante, una gara di voi stessi con voi stessi, quel voi stessi che non è più il medesimo da un attimo all’altro; quel voi stessi che, anche se saprete raggiungerlo in ogni momento della vostra esistenza, l’attimo successivo lo dovrete ancora cercare fino a quando non raggiungerete la più profonda radice di voi stessi.
Può sembrarvi frustrante tutto questo, può sembrarvi una crudele beffa dell’Assoluto, ma pensateci un momento e capirete che non è così, capirete che per allargare il vostro «sentire» è necessario acquisire sempre nuove frazioni di esso, e per poter fare ciò è necessario che anch’esso acquisti sempre nuove frazioni da porvi come mete al fine di darvi la necessaria spinta evolutiva verso un «sentire» sempre più sentito e più vero.
Scifo
Così, uomo, sei. Sei ieri, sei oggi, sei domani e vivi come una continuità questo tuo essere nel tempo, mentre è sì importante il tuo essere, ma momento per momento, così come sono importanti – momento per momento – ogni tua sensazione, ogni tua emozione, ogni tuo atto.
Costretto dalle catene con cui sei uso impastoiare te stesso, perdi la nozione del tuo «essere» presente, e in ogni attimo che vivi commetti errori di valutazione, errori che vanno anche contro la stessa logica umana che tu stesso hai contribuito a creare nei tuoi momenti precedenti. Quale errore profondo c’è nel poeta che pensa al suo amore trascorso, affidando ad immagini liriche ciò che egli chiama con convinzione amore!
Vedi, uomo, il poeta che parla con accenti lirici, dolci o tristi, o nostalgici, non sta più parlando d’amore, sebbene egli creda di farlo, credendo che la spinta provenga da quell’amore rimasto dentro di lui. Infatti quell’amore è, esiste, nell’attimo trascorso ma non è più nell’attimo in cui lo canta il poeta, perché ormai il suo sentire è diverso.
Quell’amore è dolcezza, è tristezza, è nostalgia o rammarico, o rimpianto, o dolore, ma non è più amore poiché l’amore di cui egli sta cantando con quegli accenti è solo negli attimi che egli non sta più vivendo. Se così non fosse – se fosse amore – allora esisterebbe ancora anche negli attimi del canto, ed allora il canto non sarebbe più dolcezza, tristezza, nostalgia, rimpianto o rammarico, ma sarebbe solamente amore. Quant’è difficile spiegare con le limitate parole dell’uomo il significato preciso di un tale concetto!
È a mio conforto il fatto che le mie parole sono dette per chi è, nel momento della loro lettura, in grado di comprenderle, non per chi non può o finge di comprenderle per non sentirsi ottuso rispetto agli altri.
E tu, che non comprendi, non temere di dichiarare la tua incomprensione perché essa è giusta: essa è adesso perché tu sei adesso ad un sentire che ti vieta di abbracciare compiutamente il loro significato, anche al di là degli impedimenti e delle incertezze dovute al mezzo espressivo.
È a tuo conforto il fatto che in un presente che verrà – e non ha importanza quanti altri presenti saranno necessari perché quel presente possa da te finalmente essere vissuto– tu «sentirai» il loro significato emergere alla tua consapevolezza e prenderti le mani per trascinarti nel presente successivo con il tesoro di una nuova sfumatura in più, nel bagaglio del tuo «sentire».
Segui il tuo sentire
Frase tipica delle Guide rivolta a chi chiede consiglio su come agire in situazioni difficili.
Purtroppo, spesso le Guide non possono dare indicazioni dirette sul comportamento da tenere perché, come hanno sempre detto, non possono evitare alle persone incarnate di affrontare le esperienze che devono vivere, altrimenti ne risulterebbe danneggiata la loro possibilità di comprendere dall’esperienza e, di conseguenza, quella di aumentare la propria evoluzione, rendendo nulla l’utilità dell’esperienza.
Ovviamente, la prima obiezione che viene in mente ascoltando questa frase è: «Se non so qual è il mio sentire, come faccio a seguirlo?».
In realtà, affermano i Maestri, qualunque cosa si faccia, alla fin fine, è espressione del proprio sentire, cioè della comprensione raggiunta.
È per questo motivo che esortano sempre a non essere passivi nei confronti dell’esperienza ma di cercare di interagire con essa in quanto anche commettere degli errori fornisce alla propria coscienza delle indicazioni per arrivare a comprendere dove, come e perché questi errori sono stati commessi.
Anche non fare nulla – affermano – alla fine risulta non essere inutile perché, quanto meno, segnala quali sono i punti che risultano cosi difficili da affrontare, da portare – come conseguenza interiore – resistenze così forti da tramutarsi in blocchi fisici (somatizzazioni), emotivi (instabilità emotiva) e mentali (irrazionalità e illogicità marcata).
Se vuoi cambiare la tua vita, cambiala
Secondo le Guide è molto comune proclamare di voler cambiare la propria vita ma limitarsi solo a dirlo senza fare veramente nulla per modificare quello che non soddisfa. Il problema vero, affermano, non è soltanto cambiare le situazioni che disturbano, ma riuscire a modificare il proprio modo di vivere anche le contrarietà. Riuscire a modificare questo aspetto significa mettersi nella posizione migliore per far sì che i cambiamenti esterni avvengano o, se le circostanze proprio non lo permettono, per far sì che si riescano ad affrontare con maggiore serenità.
Messaggio esemplificativo
Osserva la tua esistenza, guarda la tua vita.
Il senso di insoddisfazione cammina al tuo fianco quasi costantemente: difficilmente ti senti felice e in pace con te stesso e, anche nei rari casi in cui questo accade, basta un niente per farti ritrovare quell’insoddisfazione che, principale caratteristica del tuo Io, è pronta a manifestarsi ad ogni battito di ciglia.
Non perdere mai di vista, non dimenticare mai che il tuo compito principale è, e resta sempre, quello di comprendere, e che per poterci riuscire nella maniera più veloce, per poter rendere la sofferenza non una condizione perpetua ma uno stato transitorio è necessario che tu comprenda la tua interiorità. E per poterci riuscire nel modo migliore devi osservare te stesso mentre vivi le esperienze che la vita ti propone, una dopo l’altra. Ricorda sempre che darai un senso alla tua vita nel momento stesso in cui, osservandoti, permetterai alla tua coscienza di comprendere.
Lo so, osservarti significa anche vedere cose di te stesso che vorresti poter ignorare, e questo non ti lascia indifferente, perché significa soffrire per ciò che vorresti essere e che, invece, ti rendi conto di non riuscire ad essere.
Eppure, osservare queste cose rende la sofferenza della loro scoperta superabile, non le lascia a suppurare dentro di te come un bubbone infetto che, comunque, prima o poi scoppierà, inevitabilmente, con ben maggiore sofferenza non solo per te ma anche per chi più ti sta accanto.
Accetta e fai tua, fino in fondo, l’idea che fuggire non serve a niente, se non a protrarre per un maggior numero di vite la tua permanenza sul piano fisico, non annulla la tua sofferenza ma allunga e rende costante il tuo dolore in un tempo molto più lungo di quello che trascorrerà dal momento della tua attuale nascita al momento del tuo abbandono di questo corpo fisico che per questa vita è una parte di te.
Convinciti di questo, cerca di farlo veramente tuo, e allora persino il tuo Io dovrà arrivare a rendersi conto che distogliere lo sguardo da quelli che sono i tuoi problemi non significa annullarli.
Viola
“La mia vita è un disastro».
“Il mio lavoro non mi gratifica, né moralmente né economicamente».
“I miei rapporti affettivi sono carenti: eppure ho bisogno di amare e di essere amato».
“Non ho un posto che senta veramente mio, amicizie che senta veramente sincere, un amore che riempia la mia vita, un interesse profondo che renda pieni i miei momenti di disequilibrio…»
“La mia vita non è come vorrei che fosse».
“Il signor Lamento – diceva un mio carissimo amico – si lamenta di tutto, persino del fatto che non ha il coraggio di suicidarsi»!
Cosa posso dirti che non ti abbia già detto?
Ma, ancora una volta, questo piccolo/immenso insegnamento che il fratello Scifo vi ha portato è caduto sotto il governo del vostro Io, rendendolo una cosa vuota e inutile nel dare un senso alla vostra vita.
Infatti l’ha preso e l’ha usato per cercare di modificare l’esterno di se stesso, nell’illusione che adeguare l’esteriorità della vostra vita ai dettami dei modelli che vi suggeriscono gli archetipi transitori (e che riassumono l’idea di felicità e di bene/male o giusto/sbagliato tipiche della vostra società o del vostro gruppo sociale di appartenenza) possa davvero rendervi felici.
Triste disillusione: non è cambiando ciò che è esterno a voi stessi che potrete essere felici, che la vostra vita acquisirà valore, che la vostra esistenza avrà un senso.
Guardate gli occhi di persone che hanno molto meno di voi, che magari vivono in tanti in una capanna sgangherata, che a fatica possiedono quel poco che rende possibile la loro sopravvivenza fisica e sociale. Potreste scorgere, spesso, una capacità di amare e di godere delle piccole cose che voi avete così spesso trascurato di coltivare.
Se aveste quello che loro hanno e non quel «tanto» che avete, sareste più felici o meno felici? La vostra vita avrebbe più senso o meno senso?
Non vi è e non vi può essere una risposta a queste domande perché il problema si pone in ben altri termini, che, come dicevo, non passano all’esterno di voi ma al vostro interno.
Moti
Che cosa avete nelle vostre vite, in fondo?
Un lavoro, un conto in banca, una vettura, una televisione, dei libri, dei CD di musica, degli abiti firmati, i pranzi al ristorante, le vacanze alle isole, una vita sessuale, una vita sociale… È questo che dà il senso alla vostra vita? E allora che ragione ha di essere presente questo desiderio che manifestate così spesso di voler cambiare la vostra vita? Per avere ancora di più? Per avere caviale e champagne tutti i giorni, la Ferrari, il fine settimana a Parigi, l’avventura con una «velina», il premio Nobel….?
Allora sareste finalmente contenti, soddisfatti della vostra vita?
Non c’è bisogno che rispondiate, sappiamo e sapete benissimo la risposta: non può essere che un NO scritto a caratteri cubitali!
Margeri
Se vuoi cambiare la tua vita cambiala!
Lo so che mi potreste rispondere che ci avete provato, convinti di aver fatto del vostro meglio, di avere fatto degli sforzi immani per ottenere quel cambiamento che sentivate, sulla scorta delle mie parole, essere giusto da mettere in atto.
Ma, innegabilmente, il risultato è stato ben inferiore alle vostre aspettative, se non addirittura inesistente.
Ed ecco assalirvi il dubbio: «allora le parole di Scifo erano inutili, solamente parole dette tanto per dire, per fare sensazione ma poi, alla resa dei conti, erano prive di una vera fattibilità, e la nostra vita non può essere veramente e sostanzialmente cambiata?».
Ricominciamo da capo: Se vuoi cambiare la tua vita, CAMBIALA!
Incomincia a guardarti negli occhi, incomincia a non mentire a te stesso.
Incomincia a non fare lo struzzo che nasconde la testa nella sabbia per non vedere il pericolo in arrivo.
Incomincia a non trovarti scuse per giustificare la tua inattività.
Incomincia ad essere severo con la tua capacità di evitare le responsabilità.
Incomincia a parlare veramente con gli altri, non solo ad emettere suoni con la bocca.
Incomincia a pensare veramente a te stesso, non a tenere stretta l’immagine che vuoi dare di te, finendo per considerarla vera.
Incomincia a cambiare la tua vita, INCOMINCIA…
E se non vuoi incominciare veramente a farlo, allora, arriva almeno a chiederti perché in realtà non la vuoi cambiare davvero.
Almeno questo lo devi a te stesso e a chi ti ama. Scifo
Prendere coscienza di ciò che si vuole veramente fa parte del dare un senso alla propria vita. Come si potrebbe, altrimenti, riuscire veramente a modificarla lenendo la sofferenza che sembra incombere minacciosa appena dietro all’angolo delle esperienze che ci si trova ad affrontare?
Se si crede che c’è bisogno di cambiare la propria vita ma il cambiamento resta soltanto un’ipotesi mai messa in atto, questo può voler dire che l’ipotesi fatta non è sentita, ma è solamente un mezzo dell’Io per apparire forti e attivi nei confronti delle difficoltà che ci fanno soffrire.
Cambiare significa modificare e modificare significa non essere mai passivi al cospetto di quello che si va attraversando.
Nel momento in cui il desiderio di cambiamento della propria vita non si traduce in uno stimolo all’azione questo non può che significare che, per qualche motivo che non siamo capaci di affrontare a viso aperto, in definitiva ci sta bene vivere la vita così come la stiamo vivendo.
Sembra tutto completamente logico e, contemporaneamente, completamente privo di senso: com’è possibile desiderare di non soffrire più e, allo stesso tempo, non fare niente per annullare, modificare o, quanto meno, mitigare la sofferenza e il dolore che ci angustia?
Rodolfo
Il problema principale, ancora una volta, va ricercato nell’Io dell’individuo. L’Io, per sua natura, non è lungimirante, non ha una grande propensione a elaborare piani complessi nel tempo. Se voi osservaste con attenzione il bambino di pochi anni – ovvero l’individuo in cui l’Io è più libero di manifestarsi, non subendo ancora che solo relativamente le influenze della coscienza e quelle degli archetipi, sia permanenti che transitori – vi accorgereste subito che è sua prerogativa volere tutto e subito, adirarsi come una furia quando non ottiene immediatamente ciò che lo gratifica, reagire ad una sofferenza in maniera diretta e senza mezzi termini o aggredendone la fonte o escogitando un comportamento che possa renderla meno pesante sul momento.
La base dell’Io dell’individuo adulto è, in fondo, la stessa di quella del bambino: esso ha la stessa tendenza a vivere il più possibile nel «qui e ora»… cosa in linea con l’insegnamento, se non fosse che il «qui e ora», per quanto riguarda l’Io, è orientato non ad assaporare fino in fondo le sfumature dell’esperienza che si trova a dover affrontare, bensì a ottenere nel «qui e ora» quello che desidera e quello che lo gratifica. Indubbiamente l’Io dell’individuo, pur costruitosi intorno a quello del bambino, non è più così semplice, diretto e immediato, in quanto altri elementi sono entrati in gioco, elementi che lo hanno strutturato in maniera, ovviamente, più complessa.
Quali sono questi elementi?
Prima di tutto è entrata in gioco la coscienza, il corpo akasico, e questo ha spinto l’Io a cercare di adeguarsi alle nuove vibrazioni che lo pervadono. L’ingresso sempre più massiccio delle vibrazioni provenienti dalla comprensione in espansione mette, inevitabilmente, dei paletti alle possibili azioni dell’Io che è costretto a fare lo slalom fra questi «punti fermi» in quanto sa che non è in grado di contrastarli veramente. La tecnica più frequente che mette in atto è, allora, quella dello struzzo… opera cioè una censura per far finta di non vedere quale sarebbe il modo più giusto di agire, cercando mille motivi al suo non-agire che possano giustificargli, nel «qui e ora», il suo comportamento.
Come conseguenza del completo allacciamento del corpo della coscienza si va via via affinando la capacità di avvertire le vibrazioni che provengono dagli archetipi permanenti e anche avvertire il rintocco degli archetipi permanenti pone dei paletti al tipo di azione messa (o non messa) in atto dall’Io, il quale reagisce spesso mascherandosi da agnello, ovvero facendo di tutto perché gli altri lo considerino buono, giusto, evoluto, direi persino «illuminato».
Fino a questo punto sembrerebbe proprio che la partita non possa che essere vinta dall’Io.
Se così non è (e ringraziamo la fantasia di Chi ha creato questa complessa struttura che abbraccia l’intera Realtà) è perché l’Io si trova sbalestrato di fronte alle istanze messe a sua disposizione dagli archetipi transitori.
Questi, infatti, come certamente ricorderete, gli propongono dei modelli più semplici da accettare per lui, perché sembrano indicargli i modi più diretti e veloci per integrarsi nella società che sta sperimentando e non solo: gli suggeriscono i «modi» di interagire con quella società.
Cercando di conformarsi quanto più gli è possibile ai dettami degli archetipi transitori l’Io ritiene di poter ottenere apprezzamento, attenzione, assenso, gratificazione, cioè tutta la gratificazione e tutto l’appagamento che desidera ottenere dal suo rapporto con gli altri.
In questa maniera, si costringe da solo ad operare in un circolo chiuso che lo porta ad altalenare tra il sentire e l’egoismo, sperimentando suo malgrado le proprie reazioni e cercando di sfuggire ciò che gli provoca disagio o sofferenza.
Quando l’Io riesce a mantenere un controllo ferreo e protratto nel tempo ecco che si innescano nell’individuo quelle sintomatologie conosciute come nevrosi o psicosi, difficili da superare.
Quando il controllo è solo parziale l’Io si trova, invece, a dover in continuazione riaggiornare la propria immagine ed i propri schemi nel tentativo di correre ai ripari, operazione che rende l’individuo incostante, alternativamente in balia delle emozioni e della razionalità ma che è, in realtà, qualificabile come sintomo di quei necessari sommovimenti interiori che, sempre e comunque, accompagnano il cambiamento evolutivo dell’individuo.
Quando l’Io perde il controllo l’individuo sfugge a tutti gli schemi, diventa poco comprensibile all’osservatore esterno, le sue reazioni e azioni sono poco classificabili sulla scorta dei modelli degli archetipi transitori… ci si trova, cioè, di fronte ad un individuo evoluto.
Ombra
È evidente che la maggior parte di voi stia attraversando un’incarnazione in cui il controllo del vostro Io è solo parziale.
E, forse, è proprio l’apparente incostanza e frammentarietà che accompagna questo stadio a darvi un’impressione di voi stessi, in fondo, peggiore di quanto veramente sia.
Qual è, dunque, il senso che dovete dare alla vostra vita, a questa vostra vita così piena di idee ed emozioni contrastanti?