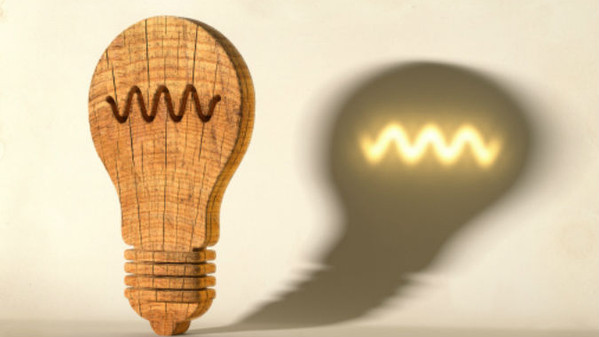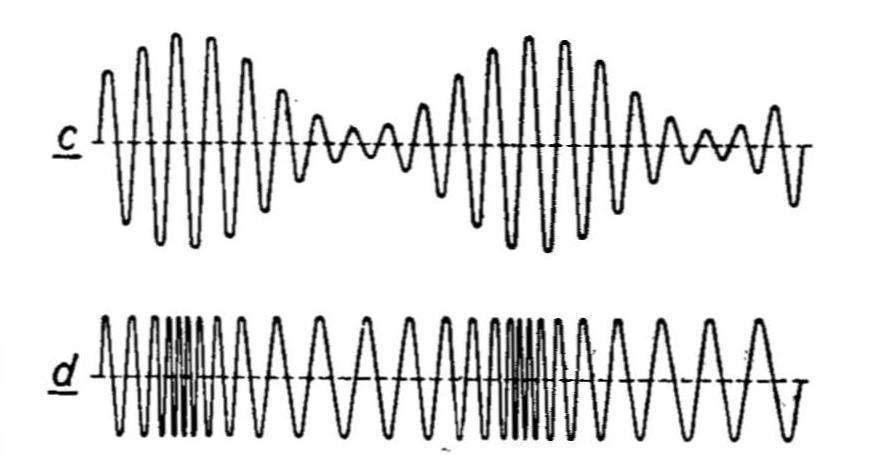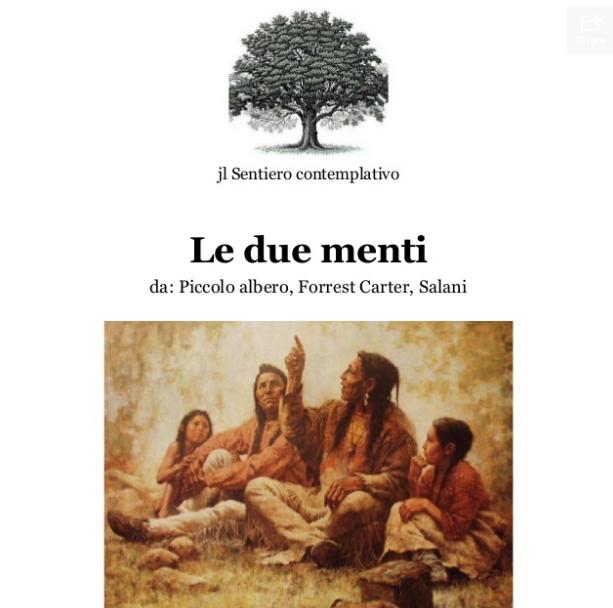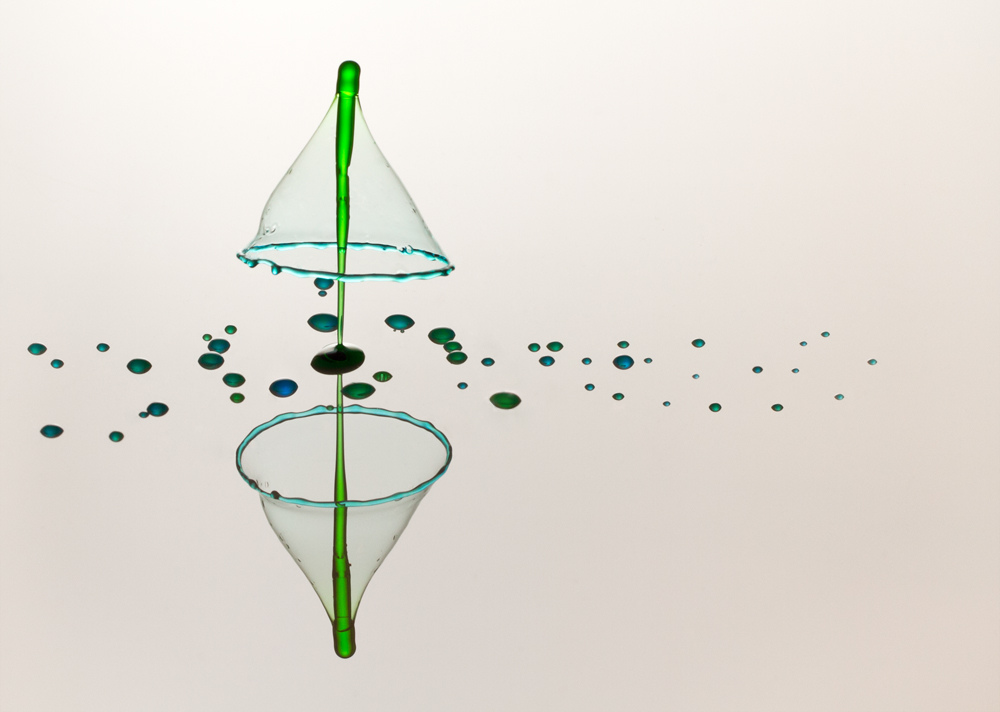A me sembra che ci sia un equilibrio nella vita tra le conferme alla nostra visione identitaria e le smentite a questa. In altri termini, nel quotidiano troviamo conferme e smentite al nostro esserci come portatori di un nome.
Senza conferme saremmo smarriti; senza smentite rimarremmo immobilizzati dalla nostra presunzione di sapere, conoscere, esserci.
Se questo può essere per la vita nel “mondo”, diverso è all’interno di un cammino spirituale.
Definiamo cammino spirituale quello che ci conduce dalla focalizzazione sul nostro esserci a quella sull’essere: la transizione dalla visione identitaria ed egoica a quella neutrale e impersonale, al ciò che è.
Constato tutti i giorni quanta confusione e quanto equivoco ci sia in merito a questo tema: le persone chiedono ad un cammino spirituale quello che mai potrà dare: la conferma di sé e del proprio esserci.
Sgomberiamo il campo da un equivoco: non sto dicendo che nella via spirituale l’identità viene negletta ed umiliata, ma che viene utilizzata come piede di porco per scardinare la porta che occlude la libertà.
La conoscenza, consapevolezza, comprensione delle proprie dinamiche identitarie sono ingredienti fondamentali per accedere a spazi di consapevolezza non condizionati: conoscere l’identità per superarla, per eliminare il filtro che essa costituisce nel tentativo di definirsi e che è l’elemento che vela la realtà dell’essere.
Conoscere dunque il filtro per non esserne condizionati.
Qualunque fatto della giornata viene piegato e usato nell’ottica di svelare il canto del proprio esserci e della resistenza a lasciare che qualcosa di più vasto si affermi.
Questo è una via spirituale: coloro che camminano con noi, il partner, i figli, i colleghi di lavoro tutti svelano il gioco tra esserci ed essere in noi.
Per poter affrontare questa dinamica interiore occorre aver risolto, almeno nelle sue principali basi, le questioni dell’immagine di sé e del proprio diritto ad esserci, altrimenti si porta nella via spirituale una aspettativa che essa non può, se non in maniera secondaria, risolvere.
Immagine tratta da: http://goo.gl/eBrDbx