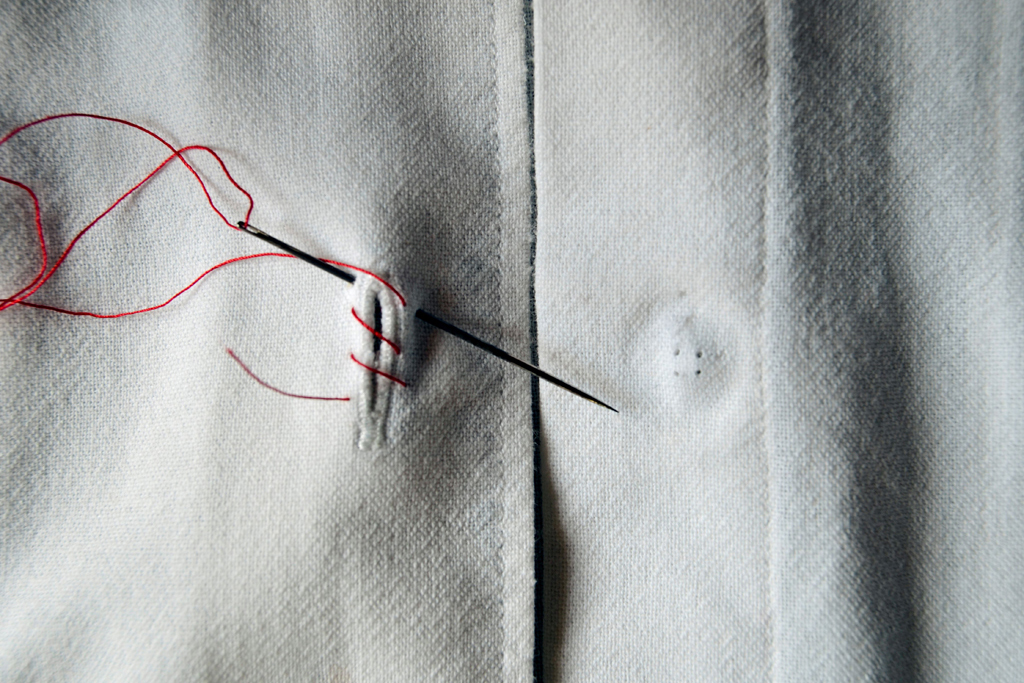Quando ho tempo e risorse, leggo ciò che scrivono Vito Mancuso ed Enzo Bianchi. Appartengono entrambi ad un mondo culturale molto lontano dal mio, ma li sento vicini nel sentire o, perlomeno, così mi pare che siano.
Ho seguito la discussione tra Mancuso e Veronesi sulla malattia e sul male (l’ultima, poco più di una settimana fa, ospiti di Fazio) e, in sincerità, mi è sembrato il dialogo di due ciechi che parlano della luce. Mi duole dire questo, lo faccio senza spirito polemico, senza pretesa di essere colui che ha visto la risposta; osservo con umiltà e con un dolore dentro questo girare attorno a questioni mal poste e come tali prive di risposta.
Da tempo volevo scrivere qualcosa sul male, su quello che gli umani chiamano male perché, dal mio punto di vista, esso non è altro che una lettura della realtà, una interpretazione: non un fatto, né una forza.
Semmai è un processo: anche la vita è un processo, non le mettiamo sopra un’etichetta univoca che la giudica, la definisce e non lo farei nemmeno nel caso del processo-male.
Il male è l’assenza del bene?
E cos’è il bene? Lo stato di salute fisica e mentale? L’unità dell’essere? La pace interiore e sociale?
Se desidero la pace, tutto ciò che non è pace rappresenta un problema.
Se sono consapevole che la pace è il frutto di un processo che dal conflitto conduce alla pace, allora mi si apre un mondo.
In questa ottica, il conflitto diviene una delle componenti del processo senza la quale non è perseguibile, né realizzabile la condizione di pace.
La pace assoluta contiene in sé tutti gli stati di pace relativi, limitati. La pace assoluta matura attraverso la pace relativa, l’assenza di pace.
Bene, male sono solo definizioni di condizioni che, in sé, sono processi, divenire, stati del sentire dove il più ampio contiene il più limitato.
Più a fondo, non esiste il processo del bene, né esiste il processo del male, esiste il processo del vivere la vita, del prendere forma e del dispiegarsi di questa ed, infine, del suo venire riassorbita.
Esistono dunque i fatti che vengono giudicati a seconda del paradigma di ognuno: il problema è lì, nel paradigma che considera la mancanza, il limite come male piuttosto che come condizione-dell’esistente-attraverso-la-quale-si manifesta-il-compimento.
Il compiuto contiene il limitato, il particolare, il frammento; l’assoluto contiene il relativo; la libertà contiene i mille gradi della non libertà.
Non esistono libertà e non libertà, esiste solo il processo della libertà: ogni non libertà prepara un grado superiore di libertà, anch’esso non libertà, fino a germogliare nella libertà assoluta che contiene in sé, che è costituita, da tutti i gradi di libertà possibili.
Se io sono nella condizione di manifestare un grado di libertà, di discernimento, di altruismo limitati, è questa una mia colpa? O non è invece lo stato dell’arte, ciò che mi svela, ciò che parla di me e mi indica la strada?
Il limite è il mio male, o la più grande delle mie possibilità?
Il limite, non denunciando una colpa, ma uno stato del sentire, cos’altro è se non il mio specchio più utile, più efficace, più trasparente, più trasformante?
Nel pensiero corrente il male viene associato alla malattia: la malattia è male. Giudicata, etichettata, archiviata, chiusa la discussione. Senza aver spiegato niente e aver capito e compreso niente. Ma pare su questo sia duro discutere, le resistenze interiori sono forti, i bastioni culturali a difesa, alti.
Sarebbe così semplice: come i fatti e i pensieri parlano di me, così pure i processi dei miei corpi parlano di me.
Scusate, ma di chi dovrebbero parlare? Pare non sia accettabile, pare sia più accettato parlare di origine ambientale, o sociale, o casuale della malattia. O di uno squilibrio non meglio definito nel sistema, magari di origine cromosomica. Si la chiave è lì, c’è un errore nel dna e così abbiamo risposto a tutto, quando non sappiamo rispondere a niente, tiriamo fuori la parola magica.
Ma non voglio parlare di ciò che non mi compete e su cui non ho competenze, mi sembra però evidente che il dna è anch’esso una risultante, il frutto di un processo.
Quando un programmatore, attraverso il linguaggio html, o altro, articola un programma, lo fa partendo da un’intenzione e da uno sviluppo di essa: quell’insieme di codici diviene poi qualcosa di fruibile ai sensi fisici umani passando attraverso una serie di mediatori. Se c’è qualcosa che ci appare come un errore nel codice, o l’ha fatto il programmatore contro la propria intenzione, oppure non è un errore, è un fatto, qualcosa di peculiare a quel programma.
La malattia è un errore? E’ un male? E’ una colpa?
La malattia è un fatto, un simbolo che narra la realtà. Quale realtà? La realtà esistenziale della persona.
La malattia non è un fatto esterno che si insinua nel nostro interno: parla di noi, dei nostri squilibri esistenziali, identitari, fisici, relazionali.
Noi e la malattia non siamo due, in sé non esiste alcuna malattia, se Roberto ha la febbre quella è la condizione esistenziale di Roberto quel giorno, quello è il Roberto di quel giorno. Quella febbre racconta qualcosa, svela qualcos’altro: è uno spot che illumina un particolare con l’intento di ricondurre a qualcosa che particolare non è, che ha caratteristiche esistenziali.
La stato che definiamo comunemente di malattia, sia fisica che psichica, è il principale indicatore, il più eclatante nel denunciare che in noi qualcosa non va: l’errore grossolano che commettiamo, è di considerare un organo, ammalato, un comportamento, sbagliato, senza cogliere il valore del sintomo che ci dice: “Sono il dito che indica la luna, il piccolo fatto che denuncia il processo!”.
Non abbiamo nessun paradigma maturo per leggere la malattia come simbolo esistenziale, ma molto è stato già fatto in alcune visioni alternative, ottusamente negate dai custodi ammuffiti dell’ortodossia.
Non abbiamo ancora gli strumenti, l’apertura mentale, l’umiltà, le comprensioni che che ci illuminino sul “dono” della malattia e del male.
Dono inteso come possibilità evolutiva, come chance di cambiamento presente e attiva, come simbolo ineludibile, come occasione che conduce a frutto.
Siamo lontani da questo, molto.
Per ora posso terminare qui; non volevo altro che avviare una riflessione; in me la visone è chiara, ma voglio che gli elementi di una evidenza si costituiscano nell’interiore di ciascuno come frutto di un processo sviluppato assieme. Se mi sarà possibile tornerò su questi argomenti in futuro.
Ho iniziato a scrivere questo post mosso dallo scoramento prodotto in me dal brano di Enzo Bianchi che sotto, in corsivo, riporto; in particolare dalla frase: “Sì, Gesù è sempre all’opera verso i nostri corpi e le nostre vite e sempre discerne, anche dove c’è soltanto la febbre, che l’essere umano si ammala per morire, che qualunque malattia è una contraddizione alla vita piena voluta dal Signore per ciascuno di noi.”
Parole che mi procurano dolore nel loro essere così lontane dalla comprensione di un’evidenza.
Questa azione con cui Gesù libera la donna dalla febbre (Mc 1,29-39) può sembrare poca cosa (“un miracolo sprecato”, ha scritto un esegeta!), ma la febbre è il segno più comune che ci mostra la nostra fragilità e ci preannuncia la morte di cui ogni malattia è indizio. Sì, Gesù è sempre all’opera verso i nostri corpi e le nostre vite e sempre discerne, anche dove c’è soltanto la febbre, che l’essere umano si ammala per morire, che qualunque malattia è una contraddizione alla vita piena voluta dal Signore per ciascuno di noi. Non fermiamoci dunque alla cronaca dell’azione di Gesù, ma comprendiamo come egli, il Veniente con il suo Regno, è in lotta contro il male e contro la morte il cui re è il demonio, colui che vuole la morte e non la vita. Gesù appare così come colui che fa rialzare, fa risuscitare – verbo egheíro, usato per la resurrezione della figlia di Giairo (Mc 5,41) e per la stessa resurrezione di Gesù (Mc 14,28; 16,6) – ogni uomo, ogni donna dalla situazione di male in cui giace. Egli vuole far entrare tutti nel regno di Dio, dove “non ci sarà più la morte, né il lutto, né il lamento, né il dolore, quando Dio asciugherà le lacrime dai nostri occhi” (cf. Ap 21,4; Is 25,8)
Brano tratto da: http://www.monasterodibose.it/preghiera/vangelo/8942-come-gesu-cura-e-guarisce