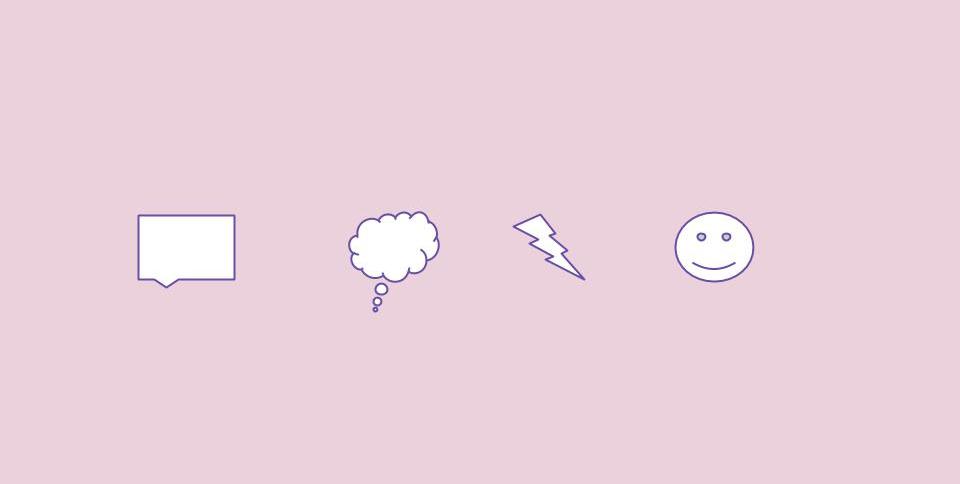Iniziamo la pubblicazione di una serie di conversazioni tra Anna Fata e Roberto Olivieri riguardanti i temi che nel quotidiano si presentano all’esperienza e plasmano l’interiore.
[Anna] Amo osservare, me stessa, gli altri, il mondo. E m’interrogo. E spesso sono più le domande che le risposte, ma non me ne curo, sono e restano capitoli sempre aperti, in lavorazione, cantieri senza fine a cui ogni tanto si aggiunge o si toglie un pezzo.
Stasera tornavamo in auto con mio padre. Un extra comunitario lo aveva aiutato a portare in auto un grosso e pesante scatolone, in cambio lui gli ha lasciato una mancia. Mentre guidava, ad un certo punto, ha rievocato la scena con questo commento: “Se un giorno diventiamo poveri a Quello lassù ricorderò che la mia parte a suo tempo l’ho data e che ora a diritto mi spetta di ricevere”.
Sorridevo, tra me e me, e insieme abbiamo condiviso la risata. Ma l’amarezza di un rapporto commerciale che sembra permeare tutta la nostra esistenza è durata per ore, e ancora me la sento addosso.
Forse sono un’illusa, ma ancora vorrei poter credere che esistano in questo mondo brandelli anche solo estemporanei e accidentali di generosità. Ma il dubbio s’insinua e mi porta a chiedere, in fondo, se ha veramente un senso utilizzare tale espressione.
[Roberto] La mente di tuo padre ha fatto quella considerazione a posteriori ma nel momento in cui dava la mancia quale era la sua intenzione?
Ha dato perché doveva? Per ricevere la divina ricompensa? Oppure ha dato semplicemente perché così gli è venuto da fare?
Non puoi sapere che cosa ha mosso tuo padre, ma puoi sapere che cosa muove te nelle mille occasioni che la vita ti presenta. Il tuo dare è condizionato dal tuo bisogno, dal dovere, da cosa?
Per parte mia ho scoperto che ci sono due livelli che operano in me e lo fanno simultaneamente: c’è un livello di fondo, una grande direttrice che ha dato e dà alla mia vita un’impronta fortemente tesa al bene comune, al bene dell’altro e c’è una sovrapposizione più superficiale che valuta, considera, pondera.
Questa parte più superficiale è quella che mi rende realista nell’andare nel mondo, che mi porta all’apertura, all’offrirmi ma con discernimento.
In questa parte confluiscono anche le resistenze, gli egoismi spiccioli, le paure..
[Anna] Per chiudere il cerchio, se devo andare a vedere, un discorso sulla generosità ha ben poco senso. Chi o cosa s’interroga sul proprio e altrui essere generoso se non l’identità? Chi ha bisogno di sentirsi gratificato da questa bella etichetta di sé o sentirsi accolto dal mondo buono e rassicurante se non l’ego?
E, allora, quando c’è il momento del dare/ricevere – già, perché in ultima analisi sono la stessa cosa, solo che nel solito nostro dualismo li vediamo separati, esattamente con noi stessi e gli altri – non c’è altro se non questa dimensione interiore.
Tutto il resto è frutto della mente: la fantasia del paradiso futuro, il senso di colpa per non avere concesso abbastanza, il ripensamento di buoni propositi per il futuro, e chi più ne ha, più ne metta …
[Roberto] Certamente è l’identità che si interroga ma essa è lo specchio della coscienza e finchè c’è la domanda: “Sono abbastanza generoso?” significa che la coscienza non ha risolto la questione. Quando l’ha risolta non c’è più domanda.
Personalmente credo che finchè c’è vita c’è quella domanda e tutti i giorni e in diverse situazioni mi interroga.
Sarebbe interessante analizzare la questione della generosità non come fatto compiuto ma come processo..
[Anna] Generosità come processo .. mi fa venire in mente per associazione che alla base della generosità ci debba essere una meta, un obiettivo di fondo..
[Roberto] Nel divenire, nelle nostre vite immerse nel tempo tutto è in successione.
La generosità non ha un fine, essa muta di pari passo con le nostre comprensioni.
La condizione dell’egoista è, potenzialmente, la più evolutiva: egli ha un ampio spettro di generosità sul quale addestrarsi..
Noi guardiamo le persone e diciamo:”Quello mi sembra un po’ egoista, quello invece ha una bella generosità!”, dovremmo considerare che entrambi stanno imparando e quindi uscire dalla morsa egoismo/generosità per guardare al processo; in questo modo lasciamo morire il giudizio e ci limitiamo a prendere atto che ognuno opera in relazione al proprio sentire, quindi a ciò che gli è possibile.
Essere generosi non è un merito; essere egoisti non è una colpa, è semplicemente la realtà di sentire differenti.
[Anna] Poi, magari, arriva un giorno in cui non notiamo più tutto ciò, perdiamo d’interesse relativamente a questi aspetti, soprattutto non soppesiamo più né il nostro, né l’altrui dare-prendere, ma iniziamo, semplicemente, a darci ..
A volte ci arriviamo senza tanto dolore, in modo quasi fisiologico, altre volte è la Vita che togliendoci tante possibilità materiali ci conduce a tale nuova dimensione.
Immagine tratta da: http://www.immaginidivertenti.org/tag/donare/