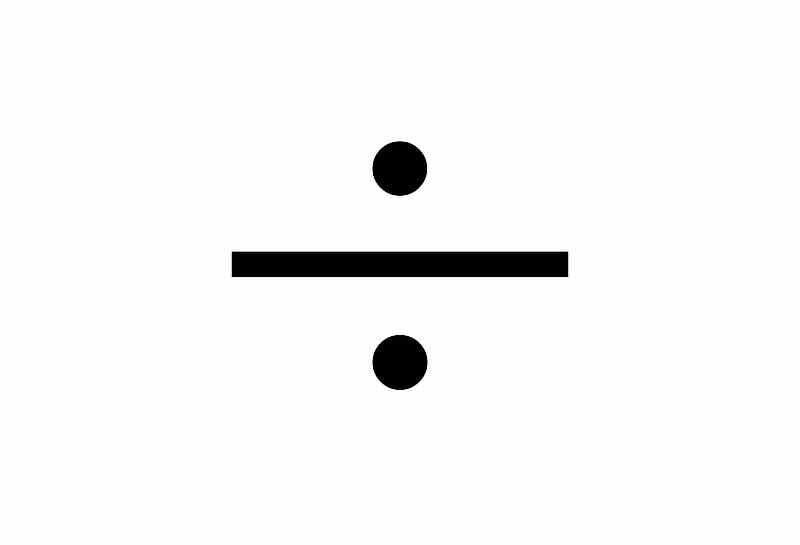Vito Mancuso parla di amore come fenomeno che si sviluppa nella dipendenza, nel possesso, nella esclusività.
Alla fine del post trovate i brani salienti evidenziati e nel link l’intera intervista a Franco Calabrò in pdf.
Vito, nel parlare dell’amore, parla di ciò che noi chiamiamo affetto e che è, per sua natura, condizionato dai bisogni delle identità che condividono l’esperienza.
Se fosse solo questo, sarebbe una questione di termini e di niente altro. Ma Vito dice che è nella logica cosmica dell’amore essere l’agente che lega, che crea dipendenza e possesso.
Qui fa una notevole confusione e temo non abbia visto bene: l’amore attiva il processo dell’incontrarsi, dell’aggregarsi e attraverso quel processo conduce al superamento di ogni dipendenza e di ogni possesso.
L’amore è processo creativo innescato da una forza unitaria, non duale: quella forza, quando impatta con l’umano, diviene processo che da un punto conduce ad un altro punto, essendo tutto nell’umano soggetto al divenire e al tempo.
L’amore conduce due persone ad incontrarsi, ad innamorarsi, a vivere la stagione della maturità affettiva condizionata ancora dal bisogno uno dell’altro, da un certo tasso di dipendenza, da una possessività di vario grado: tutto questo è mosso da quella forza chiamata amore, ma non la esprime; certo, forse, per sommi tratti, la prefigura.
Siamo ancora lontani dall’amore perché ancora alto è il condizionamento che le identità introducono.
Molti di noi arrivano a miglior vita che mai hanno, se non per lampi e frammenti, vissuto l’esperienza dell’amore.
L’amore nulla ha a che fare con la dipendenza.
L’amore nulla ha a che fare con il possesso.
L’amore nulla a che fare con l’esclusività.
Quando la persona sperimenta l’amore non può dire: “Io amo!” perché l’amore non ha un soggetto, né un oggetto.
L’amore è un’esperienza che nella gratuità sorge e diviene sperimentabile, e nella gratuità tramonta e ci lascia dentro ai nostri piccoli attaccamenti.
L’amore è la forza che ci conduce ad incontrarci, ad intrigarci, a collaborare, a condividere e, mentre viviamo questi processi, ci rende liberi dalla dipendenza, dal possesso, da noi stessi.
Man mano che l’amore si innerva in noi, trasforma l’intero ambito del nostro vivere, delle nostre relazioni, del nostro essere.
Alla fine, quando la sua azione è giunta a maturità, l’amante e l’amato sono scomparsi come soggetti che possono affermare: “Io ci sono, io amo”.
L’esperienza dell’amore è, allora, universale e copre tutti gli esseri e tutte le creature.
La coppia non esiste più in quanto tale e i due, se hanno proceduto nella comprensione assieme, sono testimoni dell’amore senza nome che accade.
Intervista a Vito Mancuso di Paolo Calabrò
[…] Questo a significare che, quando parliamo dell’amore, parliamo certamente di un sentimento – è chiaro che la prima manifestazione dell’amore sia il sentimento, all’interno del mondo degli umani – ma questo sentimento a sua volta rimanda a quella logica di cui ho parlato finora: cioè quella logica cosmica che porta gli enti ad aggregarsi ad altri enti, quelli piccolissimi come quelli grandissimi.
Se si tratta di una cosa così innata e intrinseca a tutto ciò che esiste: perché è così difficile vivere liberamente e serenamente l’amore? Perché l’uomo rimane invischiato nelle tante autocensure e regolette morali tipiche della nostra cultura? Soprattutto: si può venirne fuori? È infine possibile vivere l’amore come libertà?
Comincerei col chiarire che è colpa della cultura soltanto in parte: è vero che sono tante le istanze culturali che tendono a trasformare il “fiore” dell’amore, sbocciato spontaneamente nel campo, in fiore di serra, e poi in pianta d’appartamento (ride);in una parola, a irregimentarlo. Però qui occorre chiedersi: com’è che queste regole sopravvivono al passare dei secoli, delle organizzazioni collettive e delle morali? Una parte va certamente addebitata alla società, che non è perfetta. Ma a mio avviso tutto nasce ancor più a monte, da quel sentimento delicatissimo e peculiare che è l’amore e che non è indipendenza. Se lo si guarda più da vicino si scopre che il senso del precetto, della legge, della convenzione, non nasce semplicemente dall’imposizione eteronoma di una società cattiva: esso sorge piuttosto dalla dimensione più viva che è alla radice del fenomeno dell’amore, che è un fenomeno di dipendenza: si vuole che l’altro – o l’altra – dipenda da noi. E il legame (o il legaccio, se vogliamo evidenziarne l’aspetto negativo) è già insito in esso: ciò spiega come mai gli esseri umani, ancora oggi, si leghino tra di loro. In passato c’era il clan che assegnava a ciascuno il marito o la moglie, e c’era tutta una struttura sociale che in maniera pervasiva legava il singolo dalla nascita alla morte: non c’era spontaneità nell’amore, i matrimoni erano programmati eccetera eccetera. Ma oggi non è più così, almeno in Occidente: e tuttavia gli esseri umani sentono ancora il bisogno di legarsi. Perché dunque è così difficile ritrovare quella spontaneità originaria, oggi, dove la libertà individuale lo permetterebbe? Perché si tratta di un equilibrio delicato, perché se c’è l’amore -vorrei precisare che non sto parlando degli amori (che è tutto un altro campo, anch’esso a suo modo interessante per l’esplorazione intellettuale), dell’avventura, quella di cui canta Battisti, dove meno legacci ci sono, meglio è – insomma, se c’è l’amore, cioè quel sentimento assoluto che provoca un’attrazione irresistibile, allora c’è, per così dire aautomaticamente anche il desiderio del possesso, dell’esclusività. Quando questa cosa viene meno, si può probabilmente dire che anche l’amore, nel senso più pieno, sia venuto meno (del resto non c’è da sorprendersi: l’amore è energia, è qualcosa che va e che viene), o che forse sia entrato in una nuova fase del suo sviluppo. […]