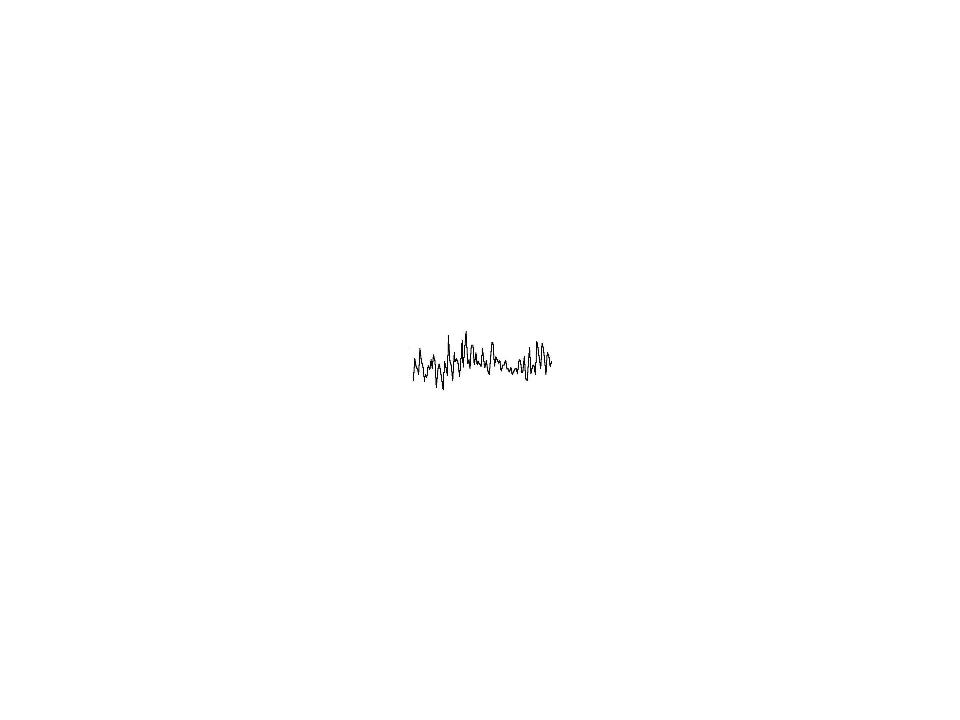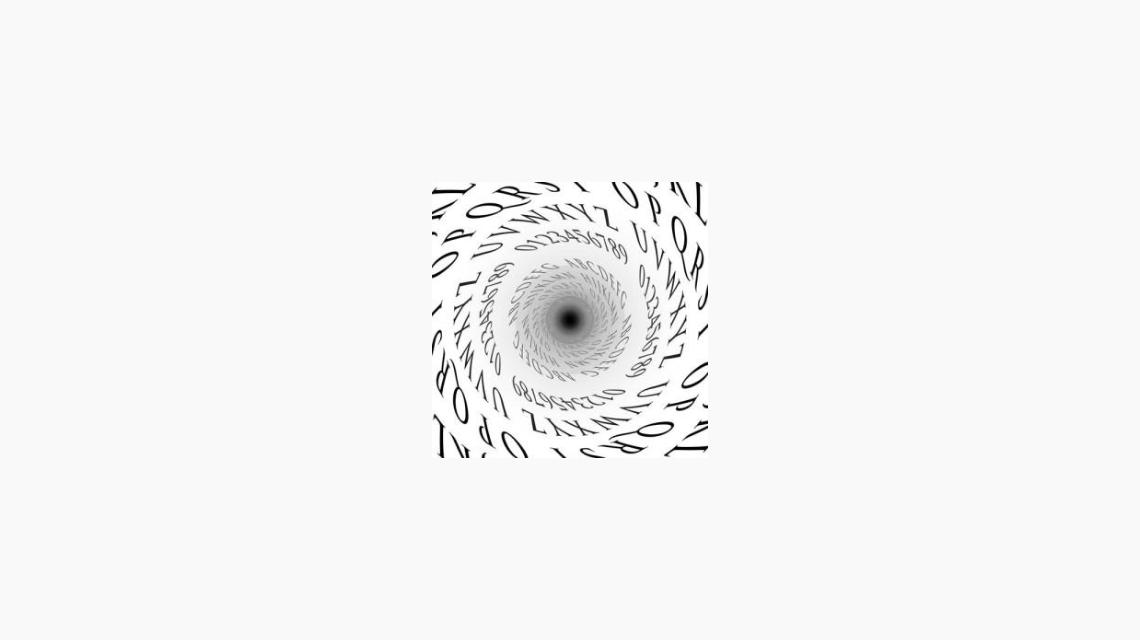Può un cammino interiore, spirituale ed esistenziale, non appoggiare su una pratica meditativa quotidiana?
Non credo, non fino ad un certo punto almeno. Vedo, purtroppo, molta approssimazione e molto dilettantismo su questo tema; molta superficialità.
Se si ha caro il proprio cammino, si è anche compreso che è necessario un ancoraggio quotidiano, un fermarsi e risiedere, un azzerare i contenuti della mente e di tutto ciò che l’identità tende ad aggiungere al reale, al ciò che è.
silenzio
Non aggiungere rumore a rumore
Quando una parola o un gesto divengono rumore? Quando esprimono il nostro solo desiderio di esserci, senza essere compenetrati di osservazione, di ascolto, di accoglienza, di reciprocità.
Allora al rumore generale assommiamo il nostro rumore e la cacofonia delle menti con i loro inutili bisogni diviene insopportabile.
La parola, il gesto che sorgono dal silenzio
Sorgere dal silenzio, da un’assenza di sé, da una non necessità di esserci.
Qualcosa sorge non con il fine di dire, affermare, dimostrare, ma perché è attivata da una domanda.
Nell’acqua calma del lago, un’onda sorge perché qualcuno vi ha lanciato un sasso.
L’acqua non aveva alcun bisogno di creare l’onda, non le mancava l’onda.
Limitare l’uso delle parole e dei segni
Nel minuscolo teatro quotidiano personale, rappresentiamo il nostro esserci con una profusione di parole, di segni e di simboli.
Bisognosi di sentirci vivi, calchiamo il piccolo palcoscenico senza curarci, spesso, né della qualità, né della quantità del rappresentato.
Un passo indietro ci farebbe bene: un silenzio in più, un segno in meno ci permetterebbero un maggiore contatto con il nostro interiore, con il sentire e ci permetterebbero di compenetrare più a fondo l’accadere.
Periodo di silenzio
Rispetteremo un periodo di silenzio.
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
La caduta provocata dall’altro parla di un non compreso nostro
Un amico caro dice: “Accade che durante un intensivo, mentre tutto diventa rarefatto e la condizione contemplativa permea l’ambiente al punto che potrebbe essere sezionata con un coltello, qualcuno non ha di meglio da fare che porre una domanda che ci fa precipitare..”
A chi non è capitata una situazione simile? L’interrompersi di una esperienza costitutiva l’intero essere a causa di una banalità!
L’ordinarietà di questi “incidenti” ha portato molti “insegnanti” a strutturare i tempi, ad aumentare il controllo, a costruire rappresentazioni spiritualmente stringenti, con ritualità precise, con atteggiamenti esteriori senza sgarro possibile, con una serietà/severità interiore cui si aderisce senza ombra.
Nulla di tutto questo abbiamo fatto nel Sentiero, né mai lo faremo. Perché?
Perché se una data esperienze interiore ci svanisce nel mentre vi siamo immersi, qualsiasi sia la causa, significa che non è ancora costitutiva del nostro essere, non è ancora compiutamente compresa ed integrata. Lo dimostra il fatto che vi siamo attaccati e quando la perdiamo ci dispiace e dobbiamo faticare per ritrovarla.
Quando lo stato contemplativo è radicato nell’essere, ovvero nulla nella mente vi si oppone, esso viene e va come il vento, non a noi obbedisce, è puro accadere gratuito.
Prima di questo, siamo attaccati alla nostra pratica e alla nostra esperienza, vorremmo proteggerla e preservarla – ed entro certi limiti è giusto farlo – ma non possiamo imbalsamare la realtà, creeremmo quelle situazioni spiritualmente affettate, pompate, sostenute, cariche di liturgia; molto lontane da ciò che coltiviamo come spontaneità, immediatezza, assenza di forma, di pretesa, di presunzione.
Siamo stati sempre lontani dalle liturgie, abbiamo coltivato una ritualità minimale lasciando che i nostri gesti fossero radicalmente ordinari, inserendo parole e situazioni che, di proposito, dissacrano. L’ironia ci è compagna fedele e il sarcasmo qualche volta ci salva.
Lo facciamo per ragioni precise: al vento non deve aggiungersi altro. All’abbandono radicale non deve coniugarsi l’attaccamento. All’apertura alla vita non va posta condizione.
La nostra disponibilità a perdere tutto deve sempre guidarci, orientarci, sostenerci: quando non siamo più tanto disposti a perdere, qualcosa ci rammenta che quello è il centro del nostro cammino.
Concludendo. Quando uno stato è interiorizzato e compreso mai viene perso, è la piattaforma su cui ci muoviamo, il nostro vivere su quello appoggia.
Un disturbo, una caduta vibratoria attivano la mente e i suoi giudizi, le sue aspettative, le sue pretese: a quella attivazione leghiamo la nostra consapevolezza e la frittata è fatta.
Ma se non sorge giudizio? Se non c’è aspettativa caduta in frantumi? Osservata l’increspatura nella mente, subito quello stato ritorna.
Se dobbiamo faticare, può essere per alcune cause:
– non riusciamo a far fluire quell’increspatura perché siamo legati al giudizio/aspettativa e quindi, su quel fronte c’è ancora qualcosa che non abbiamo ben compreso;
– l’organismo nel suo insieme ha reagito scompostamente perché quella non comprensione riguarda molti e quindi il rientro è complesso;
– la bordata è stata consistente e reiterata e in quel caso bisogna provvedere con una gestione più oculata.
Immagine di Roberto D’E.
Abbiamo perso il silenzio, o non lo abbiamo ancora scoperto?
Se potete, leggete questo bell’articolo apparso su “comune info”.
La prima parte parla della situazione, del silenzio perduto, della fretta, del scivolare sulla vita.
La seconda, della necessità di insegnare ai nostri figli a vivere sottovoce.
Vorrei fare delle considerazioni sulla prima parte: abbiamo perso il silenzio, o non lo abbiamo ancora scoperto?
La mia tesi, molto semplice, è che l’umano vive ciò che ha compreso; ciò che non vive non è perché non lo vuole vivere, ma perché non ha compreso che esiste come possibilità per sé; lo vede magari vivere dagli altri, ma non lo sente adatto a sé, praticabile per sé: nei fatti, non lo considera perché non lo comprende.
Il bel brano di Orso parla di un’altra cultura, di altre priorità esistenziali, forse di un altro sentire: il nostro mondo ha ciò che crea e questo sorge dal suo sentire, da ciò che ha compreso attraverso le esperienze e la macerazione che queste producono.
Sorge anche dalla sua cultura? Certamente, ma questa non è che il riflesso del compreso e del non compreso dei singoli e dell’insieme.
Cosa dunque possiamo fare? Vivere il compreso, testimoniarlo con grande discrezione, operare nel piccolo come nel grande perché elementi di autenticità vengano inseriti in un impianto culturale ed esistenziale caratterizzato dalla futilità.
Quello che l’autrice dice nella seconda parte dell’articolo è veramente importante, da lì si può partire sapendo che nessuno aderisce a ciò che non ha compreso, ma il proporre modelli, stimoli, pratiche, abitudini attiva processi profondi e facilita il percorso delle comprensioni in maturazione.
Se comprendiamo che ciò che l’umano vive non è il frutto della malafede – la quale, anche quando è presente, è conseguenza, non origine – ma solo della non conoscenza, della non consapevolezza, della non comprensione, allora il nostro sguardo sul mondo diviene intriso di compassione e questa è un fattore determinante nel produrre il cambiamento dei sentire, prima e ultima sorgente di ogni cambiamento.
Immagine da: http://goo.gl/51KNUk
L’ingresso nel silenzio della mente: vivere nella contemplazione del reale
Un’immagine: uscire da un ipermercato e trovarsi immersi in un bosco di faggi.
Nella faggeta non c’è silenzio, inteso come assenza di stimoli, c’è una vita che si dispiega secondo ritmi dilatati, distesi.
Nell’ipermercato c’è l’eccesso di stimoli di ogni genere.
I due esempi sono metafora della realtà della vita nella contemplazione, il primo; della vita nella mente/identità, il secondo.
E’ possibile a tutti il passaggio dall’ipermercato alla faggeta? Non lo so, credo che dipenda dal sentire di coscienza acquisito.
Coloro per i quali è possibile lo faranno: a passi lenti, o rapidi, supereranno le porte automatiche dell’ipermercato e si inoltreranno nel sentiero nel bosco, disposti a fare i conti con le proteste più o meno accese di quella parte di sé legata all’esistenza del passato.
Immagine da: http://goo.gl/gkB9U6
Oggi non userò alcuna parola polemica
E’ appena sorto il sole, ho davanti una giornata, delle esperienze, degli incontri: nell’arco di tutte le ore che mi aspettano non coltiverò alcun pensiero polemico e non pronuncerò alcuna parola critica e negativa rivolta a me, alle persone che mi stanno vicino, agli altri in generale.
Mi asterrò anche dall’usuale rosario di ingiurie rivolte ai politici, quasi fossero loro gli unici responsabile della situazione del paese.
Oggi non mi lamenterò, guarderò attentamente me stesso e mi disporrò ad un atteggiamento nuovo: mi assumerò la responsabilità delle mie intenzioni e delle mie azioni smettendo di puntare il dito sull’altro da me.
Potendo proferire dieci parole, rinuncerò alla metà di esse.
E’ una piccola cosa, ma comincio da questa.
Immagine da: http://goo.gl/qE77vc